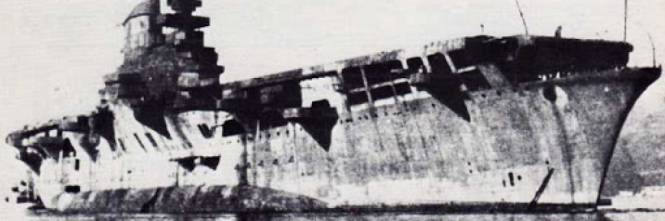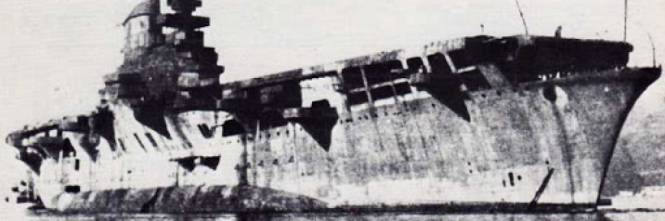
La Notte di Taranto e il destino dell’Aquila
La notte tra l’11 e il 12 novembre 1940 gli abitanti di Taranto udirono boati e videro bagliori terrificanti levarsi dalla zona del porto: gli aerosiluranti inglesi Fairey Swordfish lanciati dalla portaerei HMS Illustrious avevano sorpreso alla fonda il grosso della flotta italiana distruggendo in pochi istanti la maggior parte della capacità bellica navale di Mussolini.
L’operazione ebbe inizio il pomeriggio del 6 novembre: le navi da battaglia britanniche Malaya, Ramillies, Valiant e Warspite, la portaerei Illustrious, gli incrociatori Gloucester e York e 13 cacciatorpediniere salparono da Alessandria d’Egitto diretti verso Malta, nei cui pressi stazionava la portaerei Eagle. L’8 novembre, allarmato da queste manovre nel Mar Mediterraneo, il Comando supremo della Marina italiana inviò unità cacciatorpediniere, torpediniere e sommergibili di pattuglia nel canale di Sicilia, ma caddero nel tranello e il grosso della forza navale italiana fu fatto concentrare nella base di Taranto. Le navi britanniche raggiunsero Malta nella giornata del 10 novembre, ed il giorno seguente la portaerei Illustrious cominciò a dirigersi verso il punto prefissato per il lancio degli aerei verso Taranto. La portaerei Eagle non poté invece salpare a causa di un’avaria al motore: questo inconveniente dimezzò praticamente il numero di aerei disponibili, ma non costrinse a rinviare l’incursione.
Le ricognizioni degli aerei britannici su Taranto si protrassero fino alla sera dell’11 novembre, quando la Royal Navy apprese che nelle due rade del porto di Taranto si erano riunite le navi da battaglia Andrea Doria, Caio Duilio, Conte di Cavour, Giulio Cesare, Littorio e Vittorio Veneto, gli incrociatori pesanti Bolzano, Fiume, Gorizia, Pola, Trento, Trieste e Zara, i due incrociatori leggeri Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi e Giuseppe Garibaldi e vari cacciatorpediniere. Per citare un’espressione dell’ammiraglio Andrew Cunningham: «Tutti i fagiani erano nel nido».
A difesa del porto erano previsti 87 palloni di sbarramento, ma le cattive condizioni climatiche dei giorni precedenti ne avevano strappati 60 e non si erano ancora potuti rimpiazzare a causa della mancanza di idrogeno. E’ desolante constatare anche in questo caso come l’Italia avesse affrontato l’avventura bellica con le mani in tasca e senza nemmeno i soldi per il gelato.
In 90 minuti gli aerosiluranti della Royal Navy avevano prodotto danni ingenti, in quanto metà delle navi da battaglia italiana erano state messe fuori combattimento. Vi furono 58 morti, 32 dei quali sul Littorio, e 581 feriti, sei navi da guerra danneggiate (3 corazzate, il Cavour in maniera tanto grave che non riprese più servizio, 1 incrociatore e 2 cacciatorpediniere).
L’esito dell’incursione dimostrò quanto fosse sbagliata la convinzione secondo cui gli aerosiluranti non avrebbero potuto colpire le navi all’interno delle basi, a causa dei bassi fondali, e segnò un punto di svolta nelle strategie della guerra sul mare affidando all’aviazione imbarcata, e quindi alle portaerei, un ruolo fondamentale nelle future battaglie. A Taranto si recò anche l’addetto militare presso l’ambasciata giapponese a Roma, con l’incarico di raccogliere maggiori informazioni sul raid. A chi conosce la Storia non sfuggirà questo particolare: l’ammiraglio Yamamoto evidentemente fecero tesoro di quanto accaduto e già allora i giapponesi diedero dimostrazione della loro straordinaria abilità di “copiare migliorando”: l’attacco a Pearl Harbour ebbe probabilmente successo grazie agli insegnamenti del disastro di Taranto.
L’impresa di Taranto fruttò un encomio al Lord Ammiraglio Andrew Cunningham che aveva progettato l’attacco, mentre agli alti comandi della Regia Marina – quando all’alba le ultime fiamme furono a fatica domate – apparve del tutto evidente la letale efficacia dell’aviazione imbarcata.
Per questo decisero di dotare al più presto la Regia Marina di una portaerei che potesse arrivare ovunque nel Mar Mediterraneo. Per dar battaglia alla Royal Navy e cercare di bilanciare, sebbene con grave ritardo, le forze in campo.
Supermarina, non appena ricevuto il rapporto dei danni subiti (“Hanno colato a picco la Cavour e gravemente danneggiato la Littorio e la Duilio”, annotava quel giorno Galezzo Ciano nel suo diario, aggiungendo che “il Duce … ha incassato bene il colpo”), ordinava infatti di rispolverare un vecchio progetto del 1935 che prevedeva, già allora in chiave antibritannica, la conversione di uno scafo di grandi dimensioni per farne una portaerei: l’arma strategica che avrebbe inciso di più nelle sorti del conflitto. Nasceva così il sogno dell’Aquila: la prima portaerei italiana che avrebbe imbarcato e lanciato in battaglia gli azzurri caccia dell’Italia Littoria.
Il progetto venne affidato al colonnello Luigi Gagnotto del Genio Navale e prevedeva la conversione del transatlantico Roma, costruito per la Società “Navigazione Generale Italiana” di Genova nel cantiere Ansaldo di Sestri Ponente e varato nel 1926. Ne sarebbe risultata una portaerei di 27.800 tonnellate di dislocamento con una lunghezza fuori tutto di 232 metri. Essa avrebbe dovuto imbarcare, tra il ponte di volo, gli hangar e l’ingegnoso sistema di “sospensione” al cielo dello stesso, oltre 50 velivoli, soprattutto cacciabombardieri monomotori Reggiane Re 2001 nella loro versione navale, designata come “OR”, catapultabili ed equipaggiati con ganci d’arresto per il recupero all’atterraggio sul ponte di volo. L’Aquila sarebbe stata inoltre armata – per difendersi da naviglio e aeronautiche nemiche – con otto pezzi d’artiglieria singoli o binati da 135/45, una dozzina di pezzi antiaerei a tiro rapido da 65/54 e oltre un centinaio di mitragliere pesanti antiaeree da 20/65. L’equipaggio, compresi piloti e personale del gruppo aereo imbarcato, sarebbe stato di 1.420 uomini. Inoltre, per consentirle di stare al passo con le altre navi da guerra della Regia Marian, i motori avrebbero dovuto sviluppare una potenza sufficiente a garantire una velocità di 30 nodi per un’autonomia di 1.580 miglia marine (oltre 5mila ad una velocità media di 18 nodi). Secondo i piani di Supermarina, se l’Aquila avesse ottenuto i risultati sperati, vi sarebbe stata una seconda portaerei ugualmente progettata: la “Sparviero”.
Nell’estate del 1941, presso i cantieri Ansaldo, nonostante la carenza di acciaio e altre materie che iniziavano a scarseggiare, l’Aquila iniziò a prendere forma. Benito Mussolini non aveva compreso fin dall’inizio la vera necessità di una flotta moderna in grado di colpire anche dal cielo e da molto lontano, ma agli ordini dei comandanti alleati le flotte imperniate sulle “Aircraft Carrier” stavano letteralmente scongendo il fronte del Pacifico e nel Mediterraneo avevano salvato l’isola fortezza di Malta dall’assedio dell’Asse.
I lavori in cantiere proseguirono fino all’8 settembre del 1943; quando l’armistizio avrebbe visto passare completamente in secondo piano la necessità di una portaerei italiana. Infatti, sebbene ormai quasi pronta al varo nonostante i danni subiti durante i bombardamenti degli angloamericani ormai alleati, il 9 settembre la nave venne abbandonata al suo destino: questo non prima d’essere stata parzialmente sabotata. I tedeschi che occupavano Genova se ne impadronirono prontamente affidandola all’autorità della Repubblica Sociale Italiana. La speranza – o per meglio dire il “sogno” – era di poterla mettere in acqua come ammiraglia della Marina Nazionale Repubblicana. Così iniziarono i primi lavori per il completamento. I primi caccia “navalizzati” (una dozzina in tutto) erano già stati consegnati al Ministero dell’Aeronautica, il quale era in realtà ‘evaporato’ nel momento in cui la Regia Aeronautica divenì cobelligerante oltre che divisa dall’Aeronautica Nazionale Repubblicana. In ogni caso ci fu il tempo per convertire nuovamente quei velivoli in “caccia notturni”, lasciando più di un dubbio su cosa sarebbe potuto decollare dal ponte dell’Aquila.
Ma anche il sogno si sarebbe comunque infranto a causa delle bombe degli alleati, che cadevano senza posa sul Nord d’Italia, dove il porto di Genova fu uno dei bersagli preferiti delle “fortezze volanti”. Giacché l’Aquila si trovava ancora all’ancora a Genova, dopo essere stata centrata più volte nel giugno del ’44, i tedeschi, sempre più a corto di acciaio da fondere per produrre le armi che dovevavno difendere ciò che rimane del Reich, iniziarono a smantellarla, portando via con se ogni paratia, ogni portello, ogni vite o parte metallica in qualche modo amovibile, fosse acciaio, bronzo o anche solo ottone. L’Aquila venne disarmata e “spennata” d’ogni bullone che l’aveva composta. Si tramutò in un macabro relitto ancora prima di essere uscita dall’ombra della Lanterna. Il colpo di grazia arrivò nell’aprile del 1945: quando uno dei siluri lenta corsa copiati dagli inglesi, i “Chariot”, la raggiunse durante quella che venne denominata “Operation Toast”. I due operatori alla guida del maiale inglese, due italiani, piazzarono con successo le cariche e le fecero saltare per affondare la portaerei, impedendo ai tedeschi di affondarla altrove, per lasciare un ostacolo da ventimila tonnellate all’imboccatura del porto di Genova, approdo utile anche agli alleati per portare rifornimenti al Nord.
Rimase dunque là, semisommersa, in mezzo al porto, nel bacino di evoluzione noto come “bacino della Lanterna”, ad attendere la fine della guerra mentre la salsedine ne corrodeva le lamiere e i pesci azzurri, come gli aerei che avrebbero dovuti accogliere, nuotavano placidi negli hangar, al sicuro dal rombo delle esplosioni che sarebbero terminate solo il 2 maggio del 1945. Tre anni dopo venne rimorchiata a La Spezia per restare sempre a mezz’acqua, spogliata, ad attendere quelle riparazioni che avrebbero almeno consentito alla scafo di tornare ai vecchi fasti e riprendere il mare per uso civile. Il transatlantico Roma, del resto, aveta collegato negli anni ‘30 Genova a Napoli, e Napoli a New York. Portando passeggeri più o meno raffinati nel “nuovo mondo”, ad ascoltare il jazz e vivere l’ultimo colpo di coda degli anni ruggenti. Ma le difficoltà riscontrate nelle riparazioni e i costi altissimi previsti per riportare la “portaerei mancata” allo stato di piroscafo di linea segnarono il suo destino: la demolizione venne infatti decisa nel 1952.
Dovranno passare oltre trent’anni prima che un aereo da combattimento dell’Aviazione di Marina – non più Regia – decolli dal ponte di volo di una portaerei italiana. Nel giugno del 1983, infatti, venne varato l’incrociatore portaeromobili Giuseppe Garibaldi. Dal cui ponte decolleranno, e decollano ancora, gli Harrier. Aerei di fabbricazione inglese – quasi uno scherzo del destino – non belli e affascinanti come i Re.2001 Falco II azzurri, ma grigi uccelli assai più efficienti e micidiali, come quelli che oggi decollano dalla Cavour, la prima vera nave portaerei italiana.